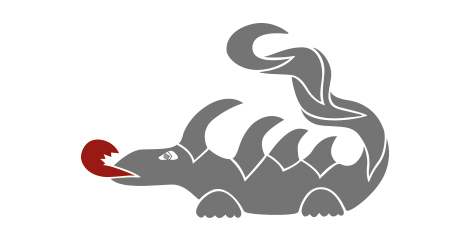di Giancristiano Desiderio
Armando De Stefano mi esortava a dargli del tu ed a
chiamarlo secondo il nome e non con l’appellativo che, secondo me, era giusto
riconoscergli: “Maestro”. Così mi sforzavo di chiamarlo Armando ma siccome avvertivo
forte in me l’imbarazzo, cercavo di ricorrere a degli espedienti avviando le
conversazioni e proseguendole senza far uso di nomi e pronomi. Però, ora che
non c’è più mi rendo conto che non solo mi rivolgo a lui – ora – dandogli del
tu ma anche prima, quando il pensiero riandava alla sua figura e alla sua arte,
mi son sempre rivolto al Maestro De Stefano come ad un amico quale lui voleva
essere e quale è stato. Quando ieri mattina ho saputo della sua morte ho
scritto d’istinto due righe come per salutarlo e sorridergli per l’ultima
volta: “La pittura era la sua vita e la sua vita/pittura non morirà, perché,
come ripeteva Keats, la bellezza è una gioia per sempre”.
Non è per nulla un modo di dire. Lui lo diceva così riferendomi
di un dialogo con il padre: “Quando mio padre, che lavorava in banca, seppe che
volevo dipingere e seguire questa mia vocazione, mi disse che con la pittura
non si campa: lui aveva davanti agli occhi certi artisti che andavano in banca
con i loro quadri sotto le braccia per impegnarli e avere qualcosa di soldi.
Gli dissi: io sono disposto anche a lavare i piatti per campare, ma per vivere
ho bisogno di dipingere”. Per campare non ha dovuto fare il lavapiatti e se avesse
voluto vendere i suoi dipinti avrebbe fatto soldi a palate. Invece, i suoi
quadri li donava, ma non a tutti: li donava solo a chi ne apprezzava la
bellezza d’arte e il valore che nel tempo avrebbero sempre più acquistato.
Armando De Stefano ha abitato, per un periodo non
breve, a Sant’Agata dei Goti insieme con la compagna Marisa Ciardiello. Prese
casa nel centro storico che tanto ammirava e amava e, come accade in questi
casi, un po’ fu per caso, un po’ fu per destino, si ritrovò ad abitare in via
Perna in quel Palazzo Desiderio, che fu della mia famiglia, e nelle stanze in
cui visse tutta la vita zio Renato Desiderio che della difesa della poesia di
Sant’Agata dei Goti fece una professione di fede. Non che a Napoli, a San
Giuseppe dei Nudi, in quel colosso di Palazzo seicentesco, stesse male ma a
Sant’Agata gli piaceva stare perché – diceva – “mi sento più tranquillo e posso
lavorare con una certa naturale concentrazione”. Infatti, non solo a San Giuseppe
dei Nudi, ma anche a Palazzo Desiderio aveva con sé cavalletti, tele, cornici,
libri e lavorava senza sosta, lavorava per riposarsi, lavorava perché “per
vivere ho bisogno di dipingere”.
Le opere d’arte figurative hanno una particolarità: o
si fanno guardare o ti guardano. Le opere di Armando De Stefano le hanno
entrambe: le guardi e le ammiri, ma dopo un po’ ti rendi conto che l’opera di
sta scrutando. Quasi sei portato a coprirti perché l’opera ti mette a nudo. Può
darsi che questa qualità maturi nella pittura di De Stefano con l’incontro con
Bacon ma è solo un passaggio nel suo percorso artistico che era destinato a
ricongiungersi alla tradizione italiana ed europea della pittura del Seicento.
Tutti i cicli pittorici di De Stefano sono “giocati” sulle tenebre e sulla
luce, come i due principi della pittura e della vita.
Armando De Stefano ha lasciato a Sant’Agata dei Goti
non poche opere: alcune si possono vedere nella Galleria d’Arte e Biblioteca M.
Melenzio della Pro Loco, come L’albero di Dafne e L’albero a Sant’Agata
dei Goti, che Claudio Lubrano ha ben custodito; altre pur essendoci non
sono, purtroppo, visibili: mi riferisco ai sei dipinti che dovrebbero ancora
essere nella Chiesa di San Francesco che è ancora inspiegabilmente chiusa. Il pittore
napoletano era molto legato a quella chiesa per vari motivi: perché era a due
passi da Palazzo Desiderio, perché vi ammirava il ciclo pittorico e biblico di
Tommaso Giaquinto, perché la sua opera Luca dipinge Maria fu incorniciata
in una cornice ottocentesca, stile impero, che aveva già ospitato un dipinto,
poi trafugato, di Luca Giordano e la grande opera era visibile a tutti tempo
addietro proprio nella Chiesa di San Francesco.
Il legame con i luoghi e con la storia era per De
Stefano importante, decisivo. E’ stato lui, come un Manzoni della pittura, a
dare dei volti ai rivoluzionari e ai reazionari, ai borghesi e ai popolani, del
1799: una rivoluzione che ebbe l’epicentro a Napoli ma che si propagò anche
nelle “province napoletane” che fino a quel momento erano quasi “un mondo a
parte”. A Sant’Agata dei Goti Armando De Stefano anche per questo si sentiva a
casa sua perché vi aveva scoperto non solo la bellezza della cittadina, così
carica di storia e passato, ma anche il legame con la tradizione artistica
napoletana, tanto che il XV secolo di Sant’Agata dei Goti è un’appendice non
piccola dell’arte napoletana. Quando si scriverà la storia estetica di Armando
De Stefano bisognerà far visita anche a Sant’Agata dei Goti, come se si volesse
scrivere un reportage per Napoli Nobilissima.