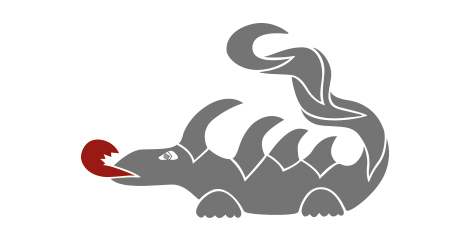di Giancristiano Desiderio
Nella cultura italiana la parola “critica” rimanda in
modo naturale alle reminiscenze liceali, alla filosofia di Kant con le sue tre Critiche
– della ragione, della pratica, del giudizio – ed a Francesco De Sanctis e alla
“critica letteraria”. Mentre, però, nel primo caso si ha un referente rispetto
per il criticismo kantiano – un po’ come accade con tutte le espressioni che
non s’intendono appieno – nel secondo caso si prende la cosa con facilità o,
addirittura, con faciloneria – come accade con tutte quelle forme culturali
ritenute secondarie o minori e che si crede d’aver non solo capito ma anche
digerito. Non è, forse, questo, proprio questo, il senso di superiorità nutrito
dalla “critica scientifica” dello strutturalismo, della semiotica, della linguistica,
ma anche dalla stilistica e dal filologismo, nei riguardi della “critica
tradizionale” di origine desanctisiana? Cosa gli scienziati del testo hanno
sempre rifiutato della cultura della critica militante se non, da una parte, il
gusto (personale) – umano, troppo umano – e dall’altra, il giudizio
(soggettivo)? La struttura, il testo, il significante servivano a superare il
soggetto, il gusto, il giudizio. La teoria della letteratura avrebbe dovuto
spazzare via la critica della letteratura. Ma quando chiesero allo
strutturalista – “Scusi, lei da dove parla?” – lui, lo scienziato
strutturalista, non rispose e tutta la sua filosofia, perché era pur sempre una
cara, vecchia filosofia, venne giù con la sua bella pretesa di teoria
scientifica oltreumana o, più semplicemente, arbitraria. Così, una volta venuta
meno la “critica scientifica” – la Teoria, la Scrittura, il Segno – che dominò
per circa un ventennio, dai Sessanta agli Ottanta, cosa è riemerso se non la
cara, vecchia “critica tradizionale”, la critica letteraria di Francesco De
Sanctis?
Tuttavia, nella storia e nella storia del pensiero o,
più in generale, della cultura e della società non vi sono mai “ritorni a…” –
“ritorno a Kant”, “ritorno a Hegel”, “ritorno a Croce” – e anche nel caso della
critica letteraria non c’è stato un ritorno alla critica di De Sanctis, di
Croce, e nemmeno di Debenedetti e, piuttosto, si è intonato periodicamente il
canto della veglia funebre per la “cara estinta”. Perché? Perché la critica è
faticosa.
Chi ha mostrato che la critica è figlia del mito di
Sisifo, dunque, è terribilmente faticosa, ma giammai inutile e, anzi, è
un’esigenza della vita umana, tanto singola quanto associata, è Massimo Onofri,
critico militante che potrei anche definire crociano, con un suo innamoramento
per Giuseppe Antonio Borgese, se le definizioni non lasciassero il tempo che
trovano. Nel suo La ragione in contumacia – una sorta di apologia della
critica – che risale al 2007 rileva che “la teoria della letteratura del
Novecento, in massima parte (dai formalisti russi al circolo di Praga, dallo
strutturalismo francese all’ermeneutica post-heideggeriana), è stata una
variante autoritaria del platonismo: d’un Platone coniugato con Saussure, Freud
e Marx, per arrivare alla convinzione che il lettore ingenuo, quello non ancora
addestrato ai misteri del metodo e della scienza della letteratura viva la sua
vita come ‘sottosopra’, dentro una realtà rovesciata che resta sempre quella,
monolitica e inossidabile, del capitalismo conclamato, dell’alienazione e del
feticismo delle merci”. E’ la storia di sempre: i comuni mortali non sanno ciò
che i re-sapienti – gli Intellettuali – sanno molto bene perché hanno scoperto
la “struttura originaria”, cara a Emanuele Severino o la verità della
necessità con la quale possono far capire, per il nostro bene, a noi
comuni mortali ciò che non abbiamo capito liberandoci dalle ombre, dalle
passioni, dagli errori, dalle catene, dal senso comune. E, invece, la critica
ci mostra che proprio il platonismo non funziona senza le ombre, senza le
passioni, senza il cavallo nero dagli occhi iniettati di sangue, senza gli errori
e, insomma, senza la mitica Caverna che è l’immagine della condizione umana. Ma la condizione umana è terribilmente faticosa, mentre sarebbe così comoda la Teoria Definitiva.
La critica, da Kant a De Sanctis a Croce e ritornando
indietro a Vico e riandando avanti a Isaiah Berlin, mostra che proprio il gusto
della vita e dell’opera bella, ciò che la teoria della letteratura avrebbe
voluto eliminare per dar corpo solo alla Lettera, è indispensabile per dare
senso alla nostra mortale condizione in cui proprio il giudizio critico, che
unisce e distingue soggetto e predicato, è il modo per relazionare essere e
divenire che sono la relazione stessa e senza questa relazione, come sapeva
Hegel e forse meglio di lui Croce, non sono. Il platonismo, che attraversa
tutta la storia del pensiero occidentale, non è il dualismo: l’eidos,
infatti, non è il caciocavallo penzolante di Labriola ma lo stesso
divenire sensibile, pensato un po’ più stabile e sensato, in cui nasciamo,
viviamo e moriamo.
La critica – in particolare la critica letteraria o d’arte
che risponde alla domanda “Perché quest’opera è bella?” – ci mostra la dimensione
estetica ed economica della nostra umanissima condizione. Quelle che Croce
chiama “le due scienza mondane” sono non solo il nostro ancoraggio al mondo ma
anche la stessa condizione di possibilità di giudicarlo, volerlo e crearlo. La
filosofia dell’arte è una modalità della vita estetica perché più che poeta
nascitur è vero che homo nascitur poeta. Poetica è l’umanità. Se
così non fosse non avremmo possibilità alcuna non solo di gustare la poesia e d’intendere
i poeti ma neanche di parlare e comunicare tra noi, non-poeti. Il mondo ci è
dato esteticamente e lo pensiamo logicamente ma sempre sulla scorta dell’intuizione
che è davvero l’aurora dello spirito, la sua alba chiara (ci va bene anche
Vasco, ma sì, dai). Ecco perché ogni critica che si rispetti non può fare altro
che avere un’estetica e una filosofia o teoria. Con la precisazione, come
giustamente avvertiva Croce, che estetica e critica sono la stessa cosa: la
differenza se c’è è solo didascalica. Perché anche il momento dello
schiarimento concettuale implica l’intuizione, il fenomeno.
L’estetica proprio in quanto tale sarà la stessa
filosofia e, insomma, l’organo della conoscenza è sempre il medesimo ossia il
giudizio storico che sarà esercitato al meglio sulla base dell’esperienza del
suo contenuto relazionale: arte, economia, calcolo, azione, vitalità. Il
giudizio, del resto, può essere esercitato solo sulla scorta della distinzione
e, per citare ancora Platone, su una concezione dell’essere in cui c’è il
primato del diverso o della differenza: altrimenti si cade o nella tautologia
dell’Uno o nell’insensatezza dei Molti. E, allora, certo che il critico non è artifex
additus artifici ma, come dice il Breviario di estetica, philosophus
additus artifici: “La sua opera non si attua se non quando l’immagine
ricevuta si serbi e si oltrepassi insieme; essa appartiene al pensiero, che
abbiamo visto superare e rischiarare di nuova luce la fantasia, e rendere
percezione l’intuizione, e qualificare la realtà, e perciò distinguere la
realtà dall’irrealtà”.
Nella critica dell’opera d’arte è proprio la facoltà
distinguente il sale della risposta alla domanda sull’eventuale bellezza.
Perché in quella distinzione l’opera va intesa nella sua genesi – possiamo anche
dire che va gustata – e va distinta da ciò che è altro rispetto a sé
stessa. L’alterità, che è dell’altro e di me stesso come altro e, quindi, della
vita, è il lavoro della critica ma anche della semplice lettura o dello
sguardo: sempre che si sia disposti a farsi dire qualcosa dall’opera e dalla
vita in genere. L’opera d’arte, come coglieva bene Heidegger al di là delle sue
involuzioni linguistiche nel saggio su L’origine dell’opera d’arte,
mette il mondo in opera o apre e istituisce mondi e la critica dovrebbe avere
la sensibilità di mostrarli avendoli intuiti e pensati. Ma a sua volta la
critica istituisce la libertà.
Questa è la sua qualità più preziosa e intima, questo
è il senso del suo essere o del suo esercizio. Non solo nel senso che se non c’è
possibilità di critica non c’è libertà, se non c’è dissenso, se non si può dire
no o non ci si può opporre è evidente a tutti, o così dovrebbe essere, che non
c’è libertà. Ma anche e soprattutto nel senso che l’esercizio della critica – il
giudizio – implica una rivoluzione o riforma cognitiva in cui la conoscenza,
anche la conoscenza scientifica, è sempre e solo conoscenza storica che per sua
natura non mette capo al titanismo del dominio assoluto dell’esistente ma molto
più semplicemente al governo limitato della vita libera. Il potere va
giustificato sul piano del sapere o della conoscenza, ma siccome con il
concetto della verità storica o della verità come storia non si dà un sapere
assoluto ne viene che il potere assoluto è un doppio abuso: una volta nei
riguardi delle vite libere che devono rispondere al governo di sé e una volta
nei confronti dello stesso potere che, non più limitato nella sua forma, perde
efficacia. La critica è, in fondo, il caposaldo della nostra vita civile e
quelle che chiamiamo Carte costituzionali sono la pietra angolare dei liberi istituti che prima di
nascere dal diritto sono partorite dalla facoltà di giudizio, dalla cultura
della libertà. Insomma, dalla critica.