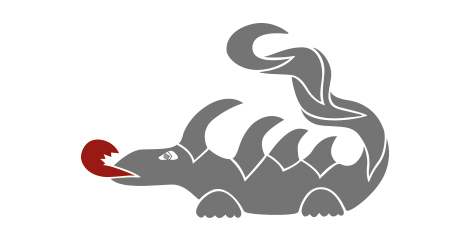di Giancristiano Desiderio
E’ un peccato che don
Antonio Abbatiello, per circa mezzo secolo parroco della Cattedrale di Sant’Agata
dei Goti, abbia scritto saggi sparsi e pubblicato poco (ma avrà scritto senz’altro
di più di ciò che è edito). Lo dico a ragion veduta perché, per fare un solo
esempio, la sua introduzione all’Origine della Città di Sant’Agata de’
Goti, ristampato tempo fa dalla Pro Loco – Fileno e la famiglia Rainone
a Sant’Agata dei Goti – è uno scritto non solo erudito ma anche di bella
fattura letteraria che invoglia alla conoscenza della storia religiosa e civile
dell’antica diocesi che fu retta alla fine del Settecento dalla figura santa e
carismatica di Alfonso de Liguori. Queste due qualità – storia religiosa e
storia civile – si ritrovano nei versi raccolti da don Antonio ne Il rotolar
de la pietra in occasione della conclusione del suo “cammino di parroco”.
Si tratta di venticinque componimenti che il sacerdote nelle “Indicazioni ai
lettori” invita a chiamare proprio così, “componimenti, senza alcuno aggettivo.
Non chiamateli poesie” perché – dice con un giusto pudore che è tipico di chi
sa cos’è poesia – “Io non sono un poeta!”.
I componimenti, però, sono
proprio il frutto del “rotolar de la pietra” perché non hanno la loro origine
in un gioco letterario ma in “circostanze vissute con una certa intensità” in
cui immagini e idee prima hanno fermentato e poi hanno spinto “la mano a
scriverle”. Dice il prete: “Perché li scrivevo? Nemmeno io lo so”. C’è da
credergli. La necessità di esprimere un sentimento è senza scopo, si direbbe
che è “senza perché” come la rosa di Angelus Silesius, e non tende ad un
obiettivo che non sia il bisogno dell’espressione. La prima volta che i
componimenti furono stampati fu quando don Antonio volle fare una prova:
lasciava singoli foglietti sui banchi della chiesa e le anime di passaggio raccoglievano
l’invito alla lettura: “Questo mi ha dato la spinta per farne una piccola
pubblicazione” per amici, parenti, conoscenti e – perché no? – sconosciuti ai
quali i componimenti potranno cadere tra le mani e potranno farsi ascoltare,
come il seme che cade in un terreno fertile.
I componimenti sono
numerati e, soprattutto per i lettori santagatesi che avranno ricevuto il libro,
potrei indicare i versi da leggere: il numero 1, il 2, il 7 e quello del terzo
gruppo – Suggestione – il 17 che è il frutto di una traduzione dal Rimas
Sacras di Lope de Vega che inizia: “Cosa possiedo io, Signor/ da farti
ricercar la mia amicizia?” e termina: “E il freddo gelido/ ha bruciato le
piaghe/ dei tuoi santi piedi/ nell’attesa del mio sì./ Se mi chiamassi ancora!/
Forse l’ora è giunta”.
Ne Il rotolar de la
pietra c’è un cammino che va dal fanciullo incantato nella “valle dei
ciliegi” al giovane sacerdote che si mette sulla “strada diretta” indicata dal
vescovo Ilario Roatta, fino a giungere alla contemporaneità in cui il tempo
sempre si compie e “resta solo l’attesa, ma senza macerare il cuore” in cui il
cuore di don Antonio, che abita i luoghi alfonsiani, dice a mo’ di appello: “Sì,
ti attendo”. Il sacerdote, che i parrocchiani hanno imparato a conoscere nel
corso degli anni e dei decenni, qui mette a nudo il suo cuore e, forse, i suoi
amici e conoscenti potrebbero anche non riconoscerlo. La pietra che rotola via
è sì la vita che va via, che passa e noi diciamo che il tempo è volato via, è
passato, mentre in realtà siamo passati noi; ma è anche la vita che è tale nell’unico
modo in cui può essere sé stessa: rotolando, divenendo, finendo. La pietra rotolata
via è anche il masso del Sepolcro che Maria Maddalena, nella mattina della Pasqua,
trova spostato e il Sepolcro è vuoto. Cos’è? E’ – dice don Antonio, ripetendo
il senso della fede cristiana ma anche il battito del cuore inquieto che è dell’uomo,
di ogni uomo – “la difficoltà di credere”: difficoltà che “sperimentavo non
solo negli uomini del mio sacro contatto giornaliero, ma anche e tante volte in
me stesso”.
La fede cristiana è una
continua riconquista del valore della vita. Sia che sia la fede religiosa, che
chiede infelice la vita eterna, sia che sia la fede laica, che crea dignitosa
la vita delle opere, c’è un bisogno della fede per dare forza al povero, agostiniano
e inquieto cuore umano, troppo umano che è continuamente visitato dal demone
della dissolvenza.