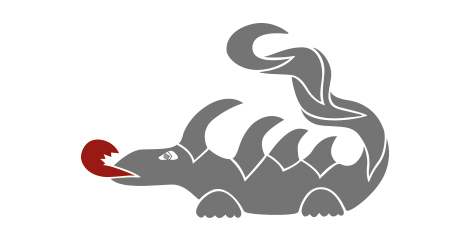di Giancristiano Desiderio
La
scuola italiana è nella condizione del mito di Narciso. Infatti, se guardiano Nello
specchio della scuola – come invita a fare fin dal titolo il libro del
ministro Bianchi (Il Mulino) – vediamo noi stessi che, come il cacciatore
Narciso innamorato della sua immagine riflessa nello specchio d’acqua,
rischiamo di cadere nello specchio nel vano tentativo di afferrarci. Francesca
Giusti sul Corriere del Mezzogiorno ha messo in rilievo tre aspetti:
competenze, autonomia, programmi. Vale la pena ritornarci su.
L’epidemia
da Covid-19 non ha creato i problemi della scuola: si è limitata, tanto per
continuare con l’utile mitologia, ad aprire il vaso di Pandora ossia la stessa
scuola da cui sono usciti tutti i mali. Tra questi il male dei mali è la
confusione che nel sistema scolastico è così sovrana che, ormai, alle parole
non corrispondono più le cose. Si prenda il primo punto: le competenze. Quali
dovrebbero essere le competenze, ad esempio, di un liceale? Sapersi esprimere
bene, avere una discreta conoscenza della cultura classica e scientifica, aver
maturato un metodo di apprendimento che gli permetta di proseguire gli studi. E
le competenze? Non ci sono perché il fine che deve perseguire la scuola è
espresso al meglio dalla celebre terzina di Dante: Considerate la vostra
semenza/ fatti non foste a vivere come bruti/ ma per seguir virtute e
canoscenza. Insomma, il fine è la didattica della conoscenza che ha come
risvolto pratico educazione e formazione. Alla parola competenza – fatta
eccezione per gli istituti tecnici e professionali che andrebbero seriamente
rivalutati – non corrisponde la cosa perché la competenza è una qualità
professionale, come quella del medico, dell’avvocato, dell’ingegnere, del
giornalista che si acquisisce sul campo. E’ necessario uscire dall’equivoco
della doppia ma verbale didattica delle conoscenze e delle competenze e per
farlo va considerato che il valore sia della scuola sia dell’università non è
nei titoli e giammai nella loro distribuzione. La produzione burocratica di
competenti genera incompetenti.
Secondo
tema: l’autonomia. Anche in questo caso ci si trova davanti ad una finzione. La
scuola, che dovrebbe essere autonoma per definizione, è totalmente eteronoma.
Gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 lo dimostrano: le scuole dipendono da
regione e ministero. Gli insegnanti non solo sono per loro stato giuridico
dipendenti ministeriali ma le stesse scuole sono sedi periferiche del
ministero. Un grande conoscitore della storia della scuola italiana, quale fu
Salvatore Valitutti, diceva che la scuola è un sistema eliocentrico: il
ministero è il sole e le scuole i pianeti che vi ruotano intorno. Oggi con
tecnologia e comunicazione in tempo reale questo sistema copernicano si è
accentuato con il risultato che le scuole, che dovrebbero brillare di luce
propria, sono ancillari rispetto al sistema burocratico che da mezzo è
diventato fine. Autonomia? La parola non corrisponde alla cosa.
Terzo
tema: i programmi. Lo dico con la felice formula che usava Gianni Vergineo,
autore di una monumentale Storia di Benevento: ciò che conta non è lo
svolgimento dei programmi, che si portano dietro un malinteso enciclopedismo,
ma interessare gli alunni a svolgere sé stessi. Ma per farlo è necessario da un
lato spostare il valore della scuola dal titolo all’insegnamento e dall’altro avere
docenti preparati, autonomi, critici mentre “il corpo docente” è il frutto della
decadenza della scuola italiana in cui, purtroppo, decenni di demagogia non si
riformano. Si scontano.